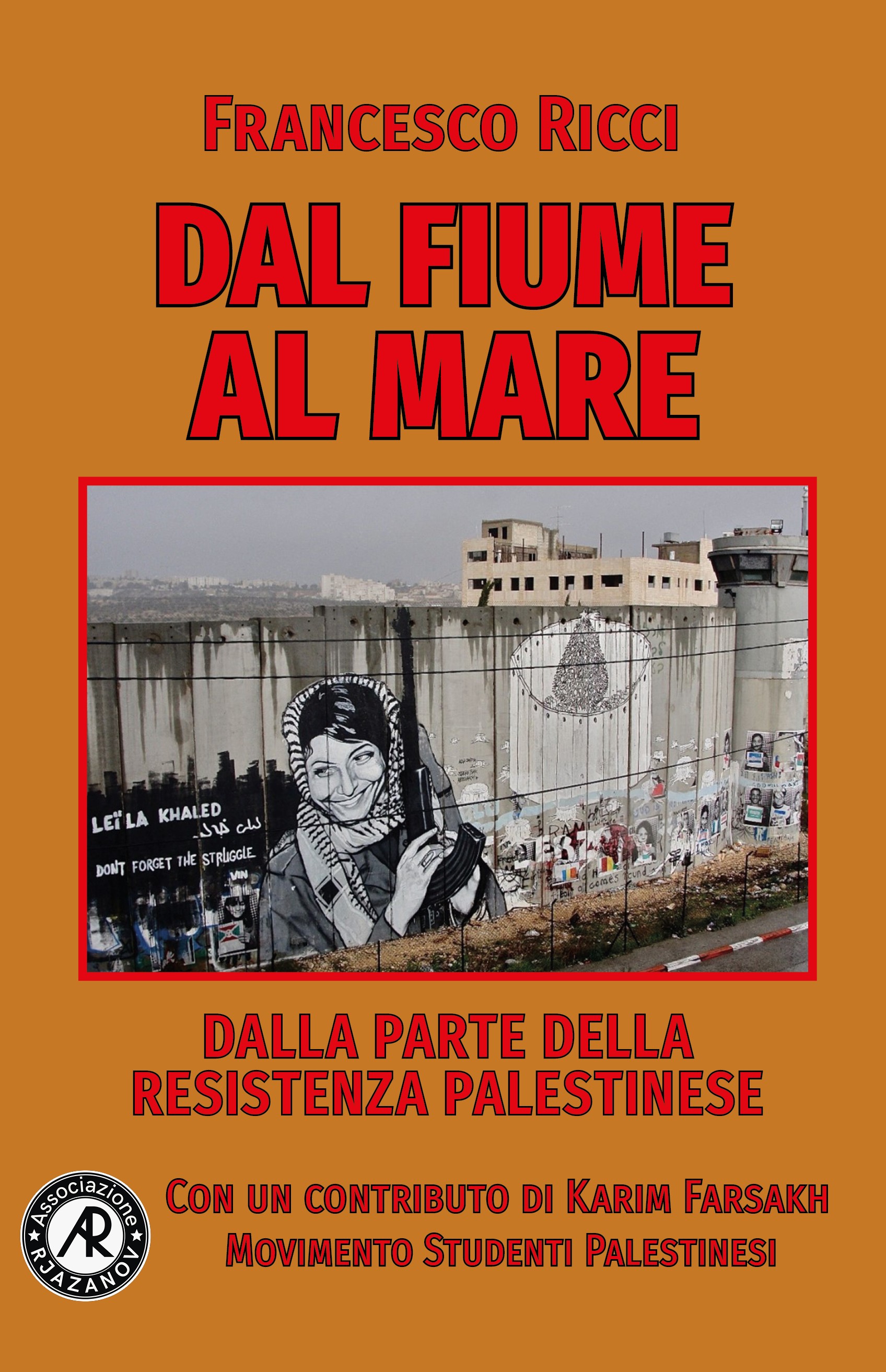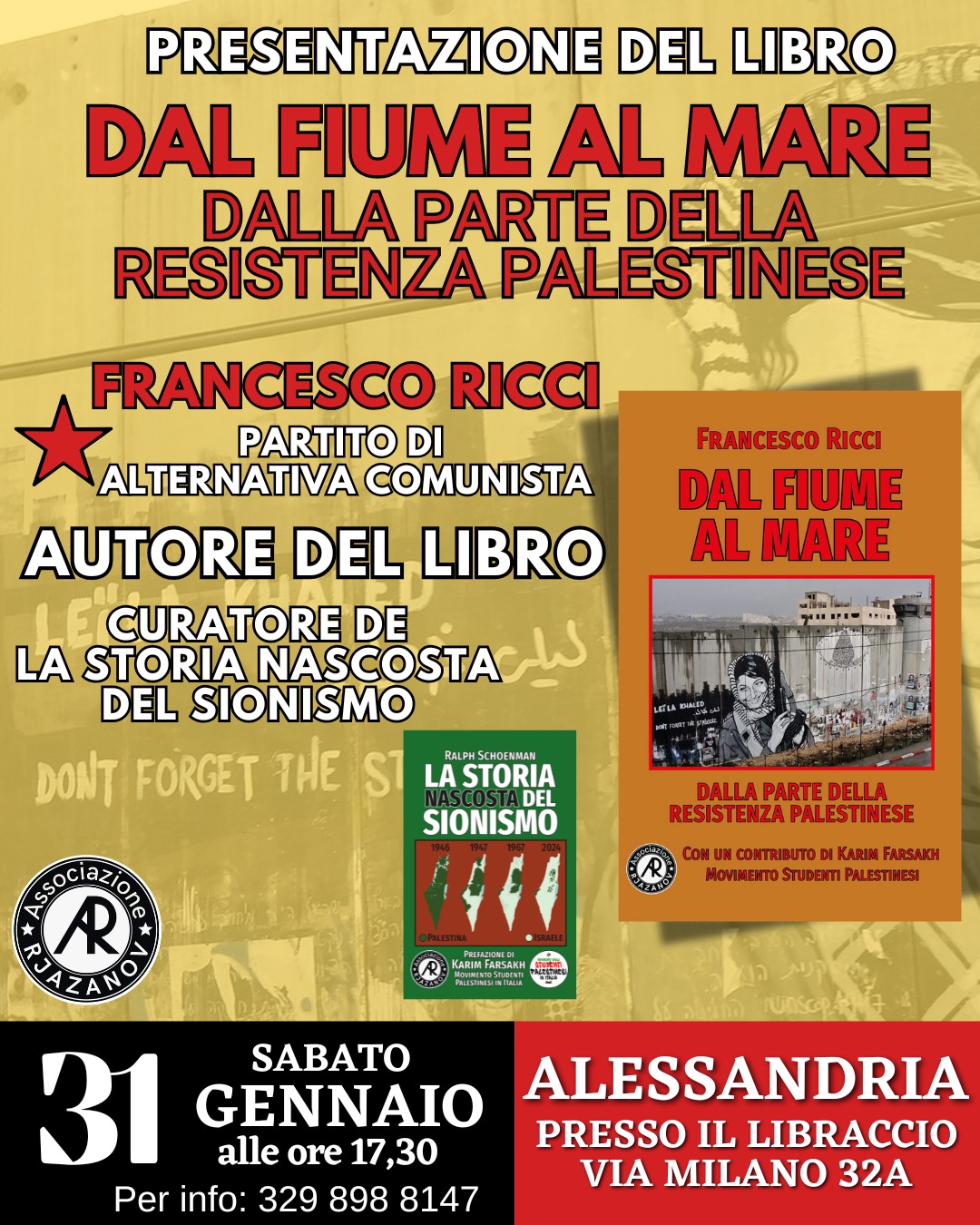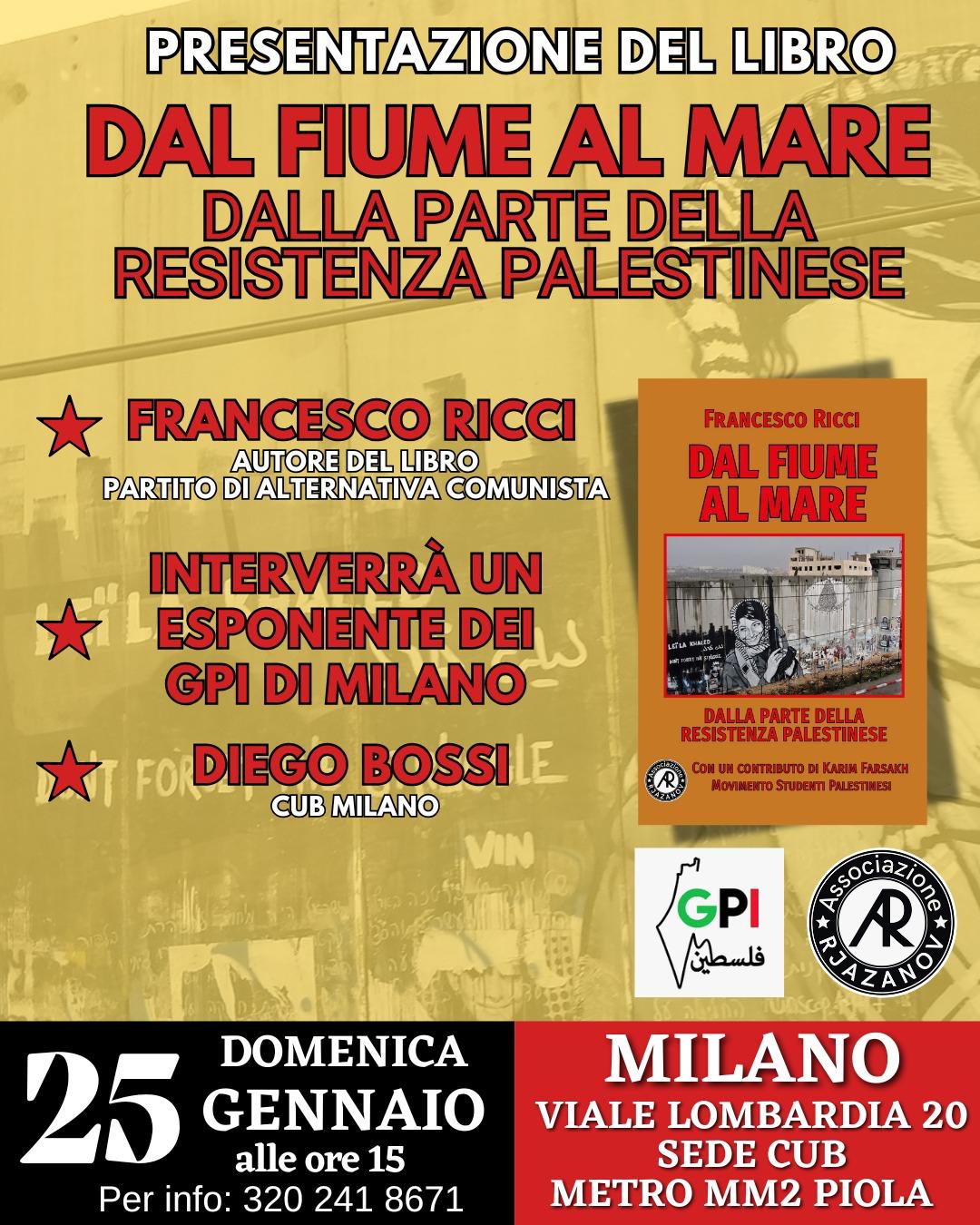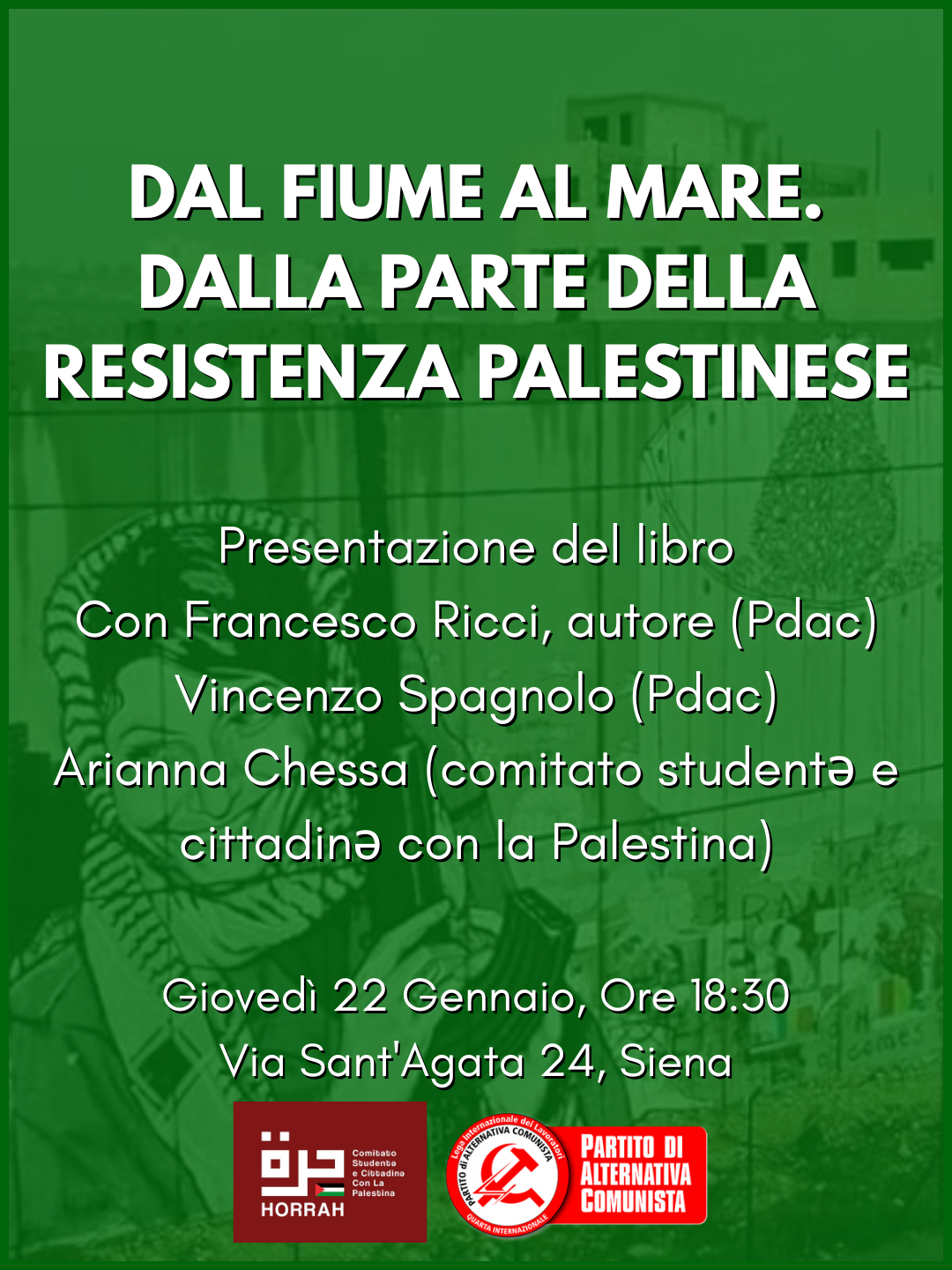Il postmodernismo, ideologia senile del riformismo*
di Francesco Ricci
«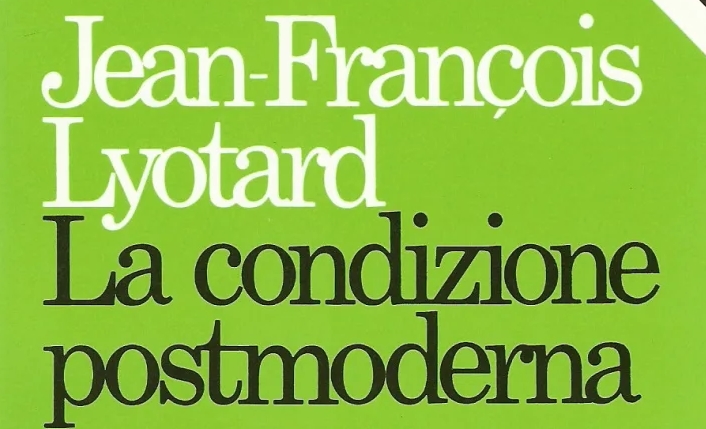
Nonostante le loro frasi che, secondo loro, "scuotono il mondo", gli ideologi giovani-hegeliani sono i più grandi conservatori. I più giovani tra loro hanno trovato l'espressione giusta per la loro attività, affermando di combattere soltanto contro delle "frasi". Dimenticano soltanto che a queste frasi essi stessi non oppongono altro che frasi, e che non combattono il mondo realmente esistente quando combattono soltanto contro le frasi di questo mondo». K. Marx, F. Engels, L'Ideologia tedesca (1846)
Descrivere le posizioni del postmodernismo è una cosa poco postmoderna. Implica infatti fare una generalizzazione basata sul ragionamento razionale, cosa che i postmodernisti rifiutano come residuo «illuministico». Per di più comporta un tentativo di trovare un filo coerente e logico in una teoria che di logico e coerente ha ben poco (1).
Un'altra complicazione viene dal fatto che sotto il nome «postmodernismo» (2) sono state raggruppate (da altri, in quanto un postmodernista degno di questo nome non accetterà mai di riconoscersi in una categoria «universale») svariate teorie e sotto-teorie (3).
Infine, a rendere più difficile il nostro tentativo, c'è il linguaggio esoterico impiegato dai postmodernisti. L'impresa assomiglia dunque a quella di chi cercasse di spiegare in termini razionali i quattro dogmi mariani. Viste le premesse, potrebbe sembrare più sensato lasciare la cosa in mano ai fedeli di questa religione laica. Se non fosse che, come accade con le altre fedi, quando pure si decidesse di non interessarsene, sono le fedi che si interessano di noi.
La filosofia postmodernista, infatti, perlomeno a partire dalla fine degli anni Settanta, è servita come copertura ideologica di una parte consistente delle politiche riformiste: anche se, è bene precisarlo, il buon vecchio determinismo non ha lasciato del tutto il campo e continua a servire allo stalinismo vecchio e nuovo e persino a un certo sedicente «trotskismo» (4).
L'oppio dei popoli in una nuova fragranza
Se per cento anni, dalla fine dell'Ottocento, il riformismo dei partiti socialdemocratici e stalinisti ha trovato nella deformazione determinista del marxismo la «falsa coscienza» con cui ingannare le masse sfruttate e oppresse, negli ultimi cinquant'anni il neo-riformismo ha scoperto nel postmodernismo uno strumento altrettanto efficace per il medesimo scopo.
Una visione determinista, teleologica, in cui il socialismo veniva presentato come un orizzonte tanto «inevitabile» come lontano; un aldilà cui corrispondeva nell'aldiquà, nell'attesa, l'accettazione del sistema capitalistico e una politica tappista nei Paesi dipendenti (prima lo sviluppo capitalistico, poi la tappa socialista) e di (illusorie) riforme nei Paesi imperialisti in sostituzione di una politica rivoluzionaria: questo è stato il tratto distintivo del riformismo da Bernstein a Togliatti e Berlinguer.
A partire dalle sconfitte delle lotte di massa degli anni Sessanta e Settanta – tradite dalle direzioni capitolarde – nelle università è stato prodotto un nuovo oppio con cui addormentare le masse. La produzione di questo oppio è aumentata esponenzialmente dopo il crollo dello stalinismo, presentato dall'ideologia borghese e riformista come «crisi del marxismo».
Ecco perché i rivoluzionari devono, loro malgrado, occuparsi di queste teorie e dimostrarne la funzione reazionaria, controrivoluzionaria.
Se Engels dovette, nell'ultimo periodo della sua vita, dedicare del tempo a confutare le astruserie dei deterministi che, travisando il marxismo che fingevano di utilizzare, riducevano la storia a una equazione di primo grado, a leggi di una fisica newtoniana applicate alla società, con un meccanismo stringente di causa ed effetto; oggi a noi tocca il compito ingrato di immergere il naso nella nuova fragranza (o, se preferite, olezzo) dell'indeterminismo postmodernista, il più recente oppio dei popoli creato in laboratorio dai riformisti.
Una farsa dopo la tragedia
Marx ebbe a scrivere (5), parafrasando Hegel, che la storia si ripete sempre due volte, la prima volta come tragedia, la seconda come farsa. E questa saggia frase viene alla mente comparando la tragedia di cento anni del riformismo classico con le teorie farsesche del riformismo degli anni nostri.
Se il riformismo classico, radicato nella classe operaia, seminava illusioni sulla riformabilità del capitalismo potendo garantire qualche briciola in una fase di relativa crescita del sistema, il riformismo attuale, privo di radicamento operaio, con le crisi economiche che si susseguono sempre più dirompenti, il pianeta in via di rottamazione, l'emergere di nuove malattie, si fa garante piuttosto della gestione di politiche anti-operaie addolcite da parole sparse come zucchero a velo su una torta. È quanto hanno fatto Podemos in Spagna, Syriza in Grecia, Rifondazione in Italia (coi due governi Prodi). Solo che ora, non potendo promettere nemmeno le briciole, bisogna convincere lavoratori e giovani disoccupati che dovranno pagare la cena ma in cambio non avranno nulla da mangiare perché i forni sono vuoti. Di più: bisogna convincerli che cibo e fame sono un equivoco e, in definitiva, che non esiste né la cena né il desco né le sedie.
Gli intellettuali postmodernisti sono riusciti, va dato atto, in un'impresa non semplice: elaborare una teoria che convinca gli operai che lo sfruttamento del lavoro salariato non esiste perché in realtà il lavoro è scomparso o è reso «immateriale» (nella cosiddetta epoca post-fordista), che sono scomparse anche le classi e quindi gli operai, e che dunque davvero non ha senso porsi l'obiettivo di costruire un partito della classe operaia.
Questa mercanzia intellettuale (che i padroni pagano bene) era però già prodotta da prima dell'emergere delle teorie postmoderniste. Il postmodernismo ha portato qualcosa in più: insieme al lavoro, agli operai e allo sfruttamento, ha fatto sparire anche la realtà stessa, che non esiste o non è conoscibile. O esiste ma solo come costruzione di un linguaggio che bisogna «decostruire».
Una trovata davvero geniale perché se non esiste una realtà oggettiva evidentemente risulta vano ogni tentativo di comprenderla e modificarla. Ecco che al marxismo fa seguito un presunto «postmarxismo», nel migliore dei casi, o direttamente teorie che (tutto sommato più onestamente) nemmeno più fanno riferimento in qualsivoglia modo al marxismo, o lo evocano solo per sputarci sopra e riempire centinaia di pagine di libri sulla fine di tutto: la fine delle classi, della lotta di classe, della storia, della realtà. L'unica cosa che pare non finire mai, se possiamo confessarlo in qualità di lettori riluttanti di questa roba, sono i libri di questi teorici, che vengono prodotti a ciclo continuo (e stampati dagli operai... scomparsi). Libri e teorie di cui, come si è detto, è necessario interessarsi seguendo il noto adagio «se li conosci, li eviti». Iniziamo allora un breve viaggio nel fantastico mondo postmodernista.
I trisavoli francesi dei postmodernisti
Ogni tanto chi si dedica a esaminare il postmodernismo è tentato di andare alla ricerca degli antenati di queste teorie. Si pesca così un elemento da questo gran minestrone e se ne cerca l'ascendenza. Forse così facendo si è fin troppo benevoli perché si trova la matrice di certe complete assurdità in teorici che, pur nei loro limiti, si muovevano in una sfera ben più elevata e per questo hanno talvolta lasciato anche cose interessanti.
Così, ad esempio, pescando col mestolo la teoria gnoseologica che accomuna la gran parte dei postmodernisti, si è trovato in Nietzsche un possibile riferimento. In particolare nella sua famosa affermazione sui fatti e sulle interpretazioni. La frase che spesso si cita si trova nei Frammenti postumi e nella versione integrale recita così: «Contro il positivismo, che si ferma ai fenomeni: "ci sono soltanto fatti", direi: no, proprio i fatti non ci sono, bensì solo interpretazioni. Noi non possiamo constatare nessun fatto "in sé"; è forse un'assurdità volere qualcosa del genere. "Tutto è soggettivo", dite voi; ma già questa è un'interpretazione, il "soggetto" non è niente di dato, è solo qualcosa di aggiunto con l'immaginazione, qualcosa di appiccicato dopo. È infine necessario mettere ancora l'interprete dietro l'interpretazione? Già questo è invenzione, ipotesi. In quanto la parola "conoscenza" abbia senso, il mondo è conoscibile; ma esso è interpretabile in modi diversi, non ha dietro di sé un senso, ma innumerevoli sensi. "Prospettivismo"» (6).
Non essendo specialisti di Nietzsche, non ci addentreremo nel dibattito... sull'interpretazione di questa frase. Certo è che un concetto così come qui viene espresso (o almeno come appare ai più) sta alla base del relativismo estremo postmodernista.
Sempre alla ricerca di antenati del postmodernismo, altri hanno tirato in ballo gli esponenti della scuola di Francoforte (7). A noi sembra una forzatura perché implica porre sullo stesso piano autori che, malgrado tutto, avevano una dignità teorica, con dei semplici ciarlatani.
Più appropriata ci sembra l'indagine che punta ai filosofi francesi cosiddetti «poststrutturalisti» Foucault, Derrida, Deleuze, e altri, che elaborarono in particolare a partire dagli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso (8). Il punto in comune tra questi autori, pur nelle differenze tra loro, e i postmodernisti è il rifiuto di una realtà conoscibile oggettivamente.
In particolare è in Foucault che possiamo trovare la tesi secondo cui il linguaggio non è un prodotto sociale ma, al contrario, costruisce la realtà sociale. Derrida riprende e sviluppa il concetto arrivando ad affermare che «il n'ya pas de hors-texte» (9), cioè che nulla esiste fuori dal testo, che non è possibile conoscere il reale al di fuori del linguaggio. Le parole e i concetti avrebbero cioè il potere di determinare il mondo materiale. Idee e parole rimandano ad altre idee e parole, si tratta di praticare quindi la «decostruzione».
In termini più direttamente politici, tuttavia, i veri padri del postmodernismo sono sicuramente Jean-François Lyotard, Ernesto Laclau e Chantal Mouffe.
Lo scetticismo di Lyotard, figlio del riflusso
Il libro di Lyotard, La condizione postmoderna (10), esce non a caso nel 1979, con l'inizio del riflusso delle lotte di massa degli anni Sessanta e Settanta.
Secondo Lyotard saremmo entrati in una nuova epoca che sostituisce la modernità: appunto l'epoca postmoderna e postindustriale. Il postmoderno sarebbe l'incredulità delle cosiddette «metanarrative», nome in cui include illuminismo e marxismo, soprattutto quest'ultimo quale «narrazione» dell'emancipazione del proletariato attraverso la rivoluzione. Si tratterebbe allora di abbandonare quelle «metanarrazioni» che pretendevano di interpretare la realtà come totalità e che nel farlo producevano una «narrazione» fittizia.
Lyotard riprende da Foucault la centralità del linguaggio e la tesi secondo cui il linguaggio crea la realtà. A partire da lì, sostiene che il potere non si incarna nello Stato della borghesia ma nella produzione di informazione e linguaggio. Nella sua lotta contro la «dittatura della realtà» Lyotard si spinge oltre e pone in discussione il concetto stesso di scienza. Si chiede, ad esempio: la teoria copernicana è vera? La sua risposta (desolante, se si considera che scrive queste cose a tre secoli e mezzo dalla morte di Galileo) è: «ciò che dico è vero perché lo provo; ma chi prova che la mia prova è vera?» (11).
In altre parole, alla relatività temporale di ogni conoscenza scientifica si sostituisce una relatività assoluta, tale per cui la scienza stessa non è altro che una «narrazione» tra le altre.
La versione italiana di queste teorie si svilupperà a partire dal libro collettivo curato da Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo, padri del cosiddetto «pensiero debole» (12).
Postmarxisti o anti-marxisti? Laclau e Mouffe
L'argentino Ernesto Laclau, con la femminista belga Chantal Mouffe, traggono, dalle farneticazioni fin qui viste, delle ricadute pratiche e politiche di cui si approprieranno i partiti riformisti, da Podemos a Syriza a Rifondazione comunista, come salvacondotto per entrare nei governi borghesi.
Il libro fondamentale dei due autori citati esce nel 1985 con l'ambizioso titolo di Egemonia e strategia socialista (13).
I due si definiscono inizialmente «postmarxisti», cioè, a loro dire, superatori ma anche continuatori di quanto di meglio hanno accuratamente scelto da un marxismo che fanno a pezzi per poi impastarlo ecletticamente con elementi tratti dalla linguistica, da Wittgenstein, dallo psicanalista Lacan e aggiungendo, prima di infornare, qualche scaglia di Gramsci. C'è per questo chi accetta di definirli «gramsciani», se non fosse che si tratta di un Gramsci sterilizzato e imbalsamato, ripulito dal suo contenuto rivoluzionario.
Dopo aver fatto, nella prima metà del libro, una caricatura della concezione materialista della storia (14) e del marxismo, riducendolo alla sua versione economicista e positivista (15), socialdemocratica e stalinista, i «postmarxisti» proclamano la morte (per la undicesima volta almeno nel solo Novecento) della classe operaia e blaterano di «nuovi soggetti» della trasformazione. Trasformazione che già non è più, va da sé, rivoluzionaria; non ha cioè per scopo di rovesciare il dominio borghese per sostituirlo con il dominio del proletariato (la dittatura del proletariato) ma si pone il compito ben più accettabile (per la borghesia) di realizzare una imprecisata «democrazia radicale».
Il passo successivo di questi autori, che già abbandonavano ogni riferimento al marxismo, inclusa la sua versione «post», è stato l'approdo a un «populismo di sinistra» (16), cioè la ricerca di un soggetto popolare dissociato delle contraddizioni di classe. E, concretamente, nell'appoggio di Laclau ai governi kirchneristi in Argentina.
Un tentativo di sintesi in tre punti
Arrivati a questo punto vorremmo provare a sintetizzare gli elementi che accomunano le varie specie e sotto-specie di postmodernisti. Proveremo quindi a enucleare un minimo comune denominatore per farci un'idea, anche se approssimativa, di cosa sostengono questi teorici. Il loro pensiero può essere così riassunto in tre punti.
1) Politica. Viviamo in una nuova era che ha sostituito la modernità: l'era postmoderna, caratterizzata da una società postindustriale, postfordista, basata sulla prevalenza del «lavoro immateriale» in cui non esistono più le classi di una volta (variante: non esistono le classi o comunque si stanno estinguendo) e dunque la società non si basa più sullo sfruttamento del lavoro salariato e la soluzione non può quindi incentrarsi su una «classe generale» (la classe operaia) che liberando sé stessa libera tutti.
In questa nuova società esistono infinite forme di oppressione e ogni settore oppresso (i «nuovi soggetti» che sostituiscono la classe) deve organizzarsi in forma separata dagli altri, in quanto solo chi soffre un'oppressione specifica è in grado di comprenderla, può parlarne e può combatterla o meglio può opporvi «resistenza».
La critica al sistema basato sulle classi e sullo sfruttamento del lavoro salariato è sostituita con una critica moralista all'individuo e agli «stili di vita» che riproducono il privilegio sui soggetti discriminati. La società si divide non secondo linee di classe ma di «privilegio»: degli uomini sulle donne (su questo si basano le teorie sul cosiddetto «patriarcato»), degli eterosessuali sugli lgbt, dei bianchi sui neri, ecc.
In conseguenza di ciò perde senso tutto il programma marxista, e cioè la costruzione di un partito operaio d'avanguardia che, guidando il proletariato (composto da uomini e donne, bianchi e neri, eterosessuali e lgbt, che vanno uniti e non divisi secondo le concezioni della «intersezionalità»), lotti per il rovesciamento rivoluzionario del dominio borghese e l'instaurazione del dominio proletario, cioè della dittatura del proletariato come transizione verso la società senza classi. Alla «vecchia» prospettiva marxista della conquista del potere, in un mondo in cui «il potere è ovunque», si sostituisce una prospettiva «postmarxista» basata su soluzioni individuali o il cui scopo è instaurare al più (nella versione di Laclau e Mouffe) una «democrazia radicale».
2) Filosofia. La prospettiva politica sopra sintetizzata si regge su una concezione filosofica. L'era postmoderna è caratterizzata dalla incredulità verso le vecchie visioni del mondo concepito come totalità («metanarrazioni»): tanto l'illuminismo della borghesia nella sua fase rivoluzionaria come il marxismo del proletariato «novecentesco» producevano una «narrazione» fittizia. A ciò va sostituito un pensiero scettico, nichilista, che si nutre di sfiducia in ogni pensiero razionale.
Non esistono fatti ma infinite interpretazioni soggettive. Non esiste verità scientifica in quanto essa è solo una «narrazione» al pari delle altre.
Piccola parentesi: si va qui, è bene rimarcarlo, ben oltre la giusta critica allo scientismo positivista o alla concezione (borghese) di una scienza indipendente in forma assoluta dalle classi e dalle ideologie: qui siamo nei fatti al rifiuto tout-court della scienza (17) in favore di un relativismo epistemico. Certo per i marxisti la scienza non è un ente neutro e indipendente (nella ricerca, nella applicazione tecnica, ecc.): ma neppure all'opposto può essere ridotta a semplice ideologia. Nella scienza, scriveva Gramsci nei Quaderni, possiamo distinguere i concetti dall'involucro ideologico, per questo «un gruppo sociale può appropriarsi la scienza di un altro gruppo senza accettarne l'ideologia» (18).
Tornando ai postmodernisti: al determinismo meccanico si sostituisce un indeterminismo assoluto. La realtà è frammentaria. O più precisamente: non esiste una realtà sociale (né naturale) oggettiva o (variante) se esiste non è conoscibile oggettivamente o (variante) esiste come mera costruzione del pensiero e del linguaggio.
In definitiva: se per Marx è l'essere sociale a condizionare la coscienza, per i postmodernisti la coscienza determina l'essere sociale o, più precisamente, è il linguaggio che determina la coscienza e dunque l'essere sociale.
3) Linguaggio. Il linguaggio assume dunque una centralità in quanto creatore della realtà e del «potere» (inteso non come potere di classe, non esistendo più le classi – vedi punto 1 – ma come entità ubiqua che impone la sua interpretazione). Le parole e i concetti hanno il potere di costruire la realtà (o meglio la sua apparenza, dato che la realtà non esiste). Col linguaggio non si esprimono significati, al contrario i significati (le idee) sono determinati dai significanti (simboli e suoni). Si tratta allora di criticare e «decostruire» il linguaggio. Non si tratta qui della «critica» nel senso marxiano, cioè materialista del termine, che ovviamente è necessaria: ma piuttosto di quella che, sbeffeggiandola, Marx ed Engels chiamavano «critica critica» (19).
Sul tema specifico del linguaggio – vista la sua importanza nel postmodernismo – vale la pena soffermarsi.
Il significato... dei significanti vuoti
Al centro della concezione postmodernista sta una confusione tra ontologia e gnoseologia, tra quello che c'è e la conoscenza di (e il metodo con cui conosciamo) ciò che c'è. Gli schemi concettuali (senza i quali ovviamente non potremmo rapportarci alla realtà) diventano la realtà stessa o la creano.
Ora, tutto questo più che un «aggiornamento» del marxismo appare come un suo abbandono.
Fu di certo già Marx, criticando (a partire dalle Tesi su Feuerbach) il «vecchio materialismo», a precisare che non esistono due entità separate e indipendenti, da un lato la natura, o oggetto della conoscenza, o materia, e dall'altra l'uomo, o soggetto della conoscenza, o coscienza. Perché se è vero che dal punto di vista ontologico la materia è anteriore alla coscienza (il pianeta è esistito molto tempo prima dell'uomo e quindi anche del pensiero) tuttavia dalla «comparsa» (attraverso il processo evolutivo) dell'uomo e (attraverso lo sviluppo del lavoro come attività sociale) della coscienza e del linguaggio, la natura ha perso la sua assoluta indipendenza e per questo non ha senso parlare di una realtà che non includa la coscienza, che è parte della realtà e al contempo la modifica. Fu Marx dunque, a differenza della caricatura che ne fanno i postmodernisti, accreditando come marxismo il dia-mat staliniano, a superare la secolare opposizione tra essere e coscienza, tra sapere e fare, tra teoria e pratica, tra soggetto e oggetto.
Però i postmodernisti si spingono ben oltre la marxiana negazione di un materialismo meccanico, cioè di un materialismo che vede la realtà sociale solo come «riflesso» della «materia» o della «economia». Rovesciando nuovamente le cose, tornano all'idealismo, e non certo a quello che Lenin ebbe a definire (parlando di Hegel) «idealismo intelligente»: no, per loro sono le «interpretazioni» a creare la realtà, o meglio ancora: è il linguaggio.
Se è vero che il soggetto non è un mero riflesso dell'oggetto (determinismo), ciò non significa che sia l'oggetto a essere un mero riflesso del soggetto (indeterminismo).
Ma i postmodernisti non si limitano a negare l'esistenza di una realtà conoscibile (per approssimazioni successive), una realtà che l'uomo al contempo modifica con la praxis mentre la conosce (come afferma Marx nella XI Tesi su Feuerbach) (20), si spingono fino a indicare nel linguaggio il creatore della realtà (il cosiddetto «linguaggio performativo») (21). Realtà che pongono sempre tra virgolette e che è creata e modificata dal linguaggio, costruita linguisticamente.
Il linguaggio, secondo i marxisti (22), è un prodotto della società e al contempo esprime e influisce sulla realtà, specie su quella sociale. Ma non è questo che affermano i postmodernisti: per loro il linguaggio ha un potere assoluto, è il demiurgo del reale. Per questo sostengono che la società è «una realtà discorsiva» e, riprendendo la «teoria francese» dei filosofi di cui abbiamo parlato sopra, attribuiscono al significante (l'involucro) una primazia sul significato (il concetto contenuto). Nel libro che abbiamo citato (23) Laclau e Muffe parlano per questo di «significanti vuoti», cioè privi di significato o «fluttuanti», cioè con molti significati.
Sfruttamento e oppressioni
Per i marxisti il cuore del sistema capitalistico è lo sfruttamento del proletariato (che è costretto a vendere la sua forza lavoro ai possessori dei mezzi di produzione), lo sfruttamento del lavoro salariato. Il proletariato è per questo l'unica classe capace di distruggere il sistema capitalistico che è la base materiale delle oppressioni, le condiziona, produce e riproduce.
Il determinismo stalinista riduce tutto ciò al solo sfruttamento, ignorando o rimuovendo la lotta contro le oppressioni.
Al polo opposto, il riformismo postmodernista rimuove lo sfruttamento e pretende quindi di combattere le oppressioni lasciando inalterato il quadro capitalistico o vagheggiando una «democrazia radicale».
I rivoluzionari pensano invece che lo sfruttamento di classe è il punto d'appoggio delle oppressioni e per questo non è possibile porre fine alle oppressioni senza distruggere il capitalismo e costruire il socialismo. Ciò non significa (come invece è per lo stalinismo) che la questione delle oppressioni vada rinviata a dopo la rivoluzione. Al contrario: è necessario combinare la lotta contro lo sfruttamento e la lotta contro le oppressioni, unendo la classe operaia che è composta da uomini, donne, lgbt, bianchi e neri, cioè da sfruttati che subiscono forme di oppressioni differenti. Per riuscirvi è necessario utilizzare un programma di tipo transitorio, che combini (e non opponga) rivendicazioni democratiche, transitorie e socialiste, come mezzo per guadagnare la maggioranza politicamente attiva della classe alla necessità di rovesciare il capitalismo per via rivoluzionaria. La lotta contro le oppressioni potrà vincere solo se costruita sulla base dell'indipendenza di classe del movimento operaio e se subordinata alla lotta per il potere rivoluzionario.
Il postmodernismo rifiuta tutto ciò e, combinandosi con le teorie sul «patriarcato», vede, ad esempio, nel sesso e non nelle classi la divisione fondamentale della società.
Judith Butler e l'individualismo queer
Judith Butler, discepola di Foucault, teorica della cosiddetta filosofia «queer», ha ulteriormente sviluppato, se così si può dire, questa concezione idealistica (24).
Se le politiche «identitarie» del femminismo piccolo-borghese puntano a dividere gli oppressi in movimenti separati basati su gruppi affini, la politica queer porta il separatismo all'estremo, sostenendo di fatto una «resistenza» individuale, basata sull'educazione dell'individuo atomizzato.
Si negano le categorie di genere e sesso (in quanto, come tutte le definizioni, avrebbero il potere di «reificare») argomentando che il genere è «costruito dal linguaggio» e quindi può essere «decostruito» col linguaggio.
Partendo dal corretto questionamento di chi pretende di ridurre il sesso a maschio-femmina (escludendo milioni di intersessuali), la Butler ne deduce la necessità di eliminare i termini maschili e femminili dal vocabolario come mezzo per eliminare l'oppressione. Come se fosse possibile inventare una neolingua (su questo torneremo poi) e soprattutto come se fosse la grammatica la causa dell'opppressione delle persone trans e non il sistema capitalistico che ha bisogno di alimentare le oppressioni per mantenere lo sfruttamento.
La teoria queer è, in definitiva, un ritorno all'individualismo borghese. Il marxismo, all'opposto, concepisce le categorie di genere e sessualità come socialmente costruite e pertanto sostiene che solo la lotta di classe le può porre in discussione; il linguaggio segue e non precede le costruzioni sociali, di classe.
Lo schwa e una neolingua orwelliana
Se fin qui ci siamo dedicati a riassumere la parte seria (per quanto possa sembrare strano) del postmodernismo, vale la pena dedicare qualche riga anche ad alcune conseguenze che, nate nel calduccio di qualche università o in salotti piccolo-borghesi, si vanno diffondendo in particolare tra i giovani e nel femminismo piccolo-borghese.
Come abbiamo visto, per i postmodernisti, avendo rimosso le classi, i comportamenti individuali sono la gran parte del problema. Di qui che la soluzione starebbe nella «autocoscienza», nella riflessione sui propri «privilegi» e sul linguaggio.
La cosiddetta «ideologia woke» (25), che si diffonde dalle accademie statunitensi, prescrive di sorvegliare il proprio linguaggio e quello altrui come forma non (come sarebbe corretto) per essere consapevoli dell'uso di classe che viene fatto del linguaggio quale ausilio per veicolare le discriminazioni, bensì con la pretesa che sia questo il modo per far scomparire le discriminazioni.
In altre parole (l'espressione è quanto mai appropriata...), eliminando alcune parole, alcuni significanti, si inibisce o almeno contrasta il contenuto discriminatorio, il significato.
I giornali di destra dedicano spesso un facile sarcasmo al linguaggio «politicamente corretto» o al «linguaggio inclusivo», addebitando il tutto sul conto di una imprecisata «sinistra» (in cui includono rivoluzionari e «progressisti»), volendo così dimostrare come ogni idea di eguaglianza (a maggior ragione il comunismo e l'abbandono dei cosiddetti «valori occidentali») sarebbe impregnata di intolleranza, per cui se scegli l'eguaglianza rinunci alla libertà.
Tuttavia il fatto che questa concezione del «linguaggio inclusivo» venga attaccata dagli intellettuali di destra non significa che vada difesa: il nemico del nostro nemico non è nostro amico.
Chiariamo: è positivo e utile tenere presente che la società, con il suo bagaglio di sfruttamento e oppressione, si manifesta anche attraverso il linguaggio. Ma non è questa banale verità che interessa ai postmodernisti. Come abbiamo visto, per loro è al livello del linguaggio che si modificano le cose.
È da questa tesi generale (una forma impoverita di idealismo) che discendono posizioni grottesche, su cui spesso si concentra l'attenzione del dibattito giornalistico, che arrivano a correggere, se non a censurare, parole e libri in cui si impieghi un linguaggio «non inclusivo».
Di lì la lista di parole che non vanno pronunciate nemmeno per stigmatizzarne l'uso, pena provocare un possibile disagio in chi ascolta.
Dalle parole ai concetti il passo è breve. Dato che solo un settore che vive una certa oppressione sarebbe in grado di comprenderla, bisogna evitare di riferirsi (anche per stigmatizzarle) a certe oppressioni, per non suscitare malessere in chi ascolta. Procedendo su questa via, in alcune università statunitensi (qui da noi la cosa è ancora agli inizi) si arriva al paradosso per cui ci sono argomenti (come il razzismo) che diventano tabù perché potrebbero turbare una identità oppressa.
La versione «soft» di tutto questo sta nell'uso dello schwa (26) e nei goffi tentativi di eliminare il genere grammaticale dalle lingue che lo possiedono. Una pratica che, per prima cosa, si basa sulla confusione tra genere grammaticale e genere, e che presuppone ignorare il fatto che molte lingue che non hanno il genere (come il turco o l'iraniano) non per questo si parlano in Paesi molto avanzati nella lotta all'oppressione delle donne.
La crociata contro le desinenze è al contempo basata sull'ignoranza, elitaria e irrealizzabile.
Sull'ignoranza perché le lingue non sono costrutti artificiali che possano essere modificati a piacimento.
Elitaria perché questo linguaggio presuntamente «inclusivo» esclude (quando viene adottato) la gran parte dei parlanti di una lingua: e – cosa per noi fondamentale – in primo luogo esclude la gran parte del proletariato che, a differenza dei piccolo-borghesi, non ha gli strumenti per (né la possibilità di) dedicarsi a giochi linguistici.
Irrealizzabile perché lo schwa e altri stratagemmi «inclusivi» sono quasi impossibili da usare nei testi e del tutto impossibili da usare nella lingua parlata. Un conto è infatti introdurre un neologismo, un conto è pensare di cambiare la costruzione delle frasi, le desinenze delle parole. La morfologia e la sintassi non possono essere modificate per decreto, come dimostra il fatto che i tentativi di lingue artificiali sono regolarmente falliti.
Ma il punto vero non è ovviamente lo schwa. È che questa e altre sciocchezze anti-scientifiche sono solo la parte visibile (spesso quella che attrae il dibattito dei talk show) di una ben più pericolosa teoria generale che vede il linguaggio come creatore della realtà e delle oppressioni e dunque che sostituisce la lotta di classe per cambiare la realtà e combattere le oppressioni con la «decostruzione» del linguaggio o l'invenzione di una neolingua, come nel romanzo 1984 di Orwell (27).
Una miseria filosofica
Un secolo e mezzo di incrostazioni deterministe e positiviste, usate dal riformismo socialdemocratico e poi staliniano, sono state sostituite dal postmodernismo. Postmodernismo che usa la caricatura determinista del marxismo per decretarne la «crisi» e tornare a una forma di idealismo impotente di fronte alla realtà quanto il materialismo volgare.
Come si diceva all'inizio, il determinismo non è scomparso dal movimento operaio. Lo ritroviamo in formazioni staliniste e anche in alcune che, sicuramente per equivoco, si richiamano al «trotskismo». Tuttavia nei movimenti giovanili e delle donne è invece, in genere, l'indeterminismo postmodernista a predominare.
C'è un motivo, crediamo, che spiega questo cambio della guardia (sempre a difesa del dominio borghese) tra determinismo e postmodernismo. Il determinismo è stata l'ideologia prevalente del riformismo nell'epoca in cui la borghesia poteva (e doveva) fare alcune concessioni. In quell'epoca la presunta «inevitabilità» del socialismo, figlia di una concezione teleologica, determinista, serviva a rinviare la lotta nell'attesa del «sol dell'avvenire», godendo tuttavia di qualche briciola concessa dai padroni.
Il neoriformismo odierno, nato e cresciuto in una situazione di crisi sempre più devastanti del capitalismo, chiamato a gestire direttamente le politiche anti-operaie dei governi borghesi, senza nessuna possibilità di vantare nemmeno piccole riforme, è stato costretto a secernere un bozzolo ideologico adeguato: di qui la teoria sulla scomparsa delle classi e la cancellazione del socialismo anche da un lontano orizzonte.
Si passa così dalla promessa domenicale di un socialismo dei secoli futuri a una cancellazione del socialismo anche dalla messa domenicale. La critica-critica sostituisce così la critica delle armi, per dirla con Marx. La realtà concreta dello sfruttamento del lavoro salariato e delle oppressioni incardinate nel sistema è sostituita da una realtà liquida. Non più la lotta di classe come motore della storia ma la ben più innocua «decostruzione» del linguaggio. Tutte cose che certo non impensieriscono la borghesia che, per questo, sentitamente ringrazia, finanziando gli autori di questa miseria filosofica, stampandone e diffondendone i libri, promuovendone le carriere universitarie.
Il riformismo, sia esso portatore di una filosofia determinista o postmodernista, si conferma in definitiva come il principale puntello del dominio capitalistico, portando nel movimento operaio e nelle lotte delle masse sfruttate e oppresse il paralizzante veleno ideologico borghese. Non è cosa nuova. Anche se, va riconosciuto, raramente in passato la miseria filosofica ha raggiunto le... vette del postmodernismo.
Ecco allora che la battaglia per una prospettiva rivoluzionaria implica una battaglia contro le ideologie utilizzate dall'opportunismo per mascherare la collaborazione di classe o deviare le lotte verso binari morti. Ciò significa riscattare quello che già due secoli fa Marx chiamava «nuovo materialismo», ossia la marxiana concezione materialistica della storia, la «filosofia della praxis», che è sintetizzata nell'articolo di Fabiana Stefanoni in questo stesso numero della rivista.
Per concludere. Senza dubbio è positivo che un numero crescente di giovani, che partecipano ai movimenti contro l'oppressione maschilista, contro la distruzione ambientale, contro il razzismo e il fascismo, cerchino una teoria che li guidi nella lotta contro il sistema capitalistico che tutto questo produce. Ma è bene avvisarli che non troveranno nessuna teoria adeguata nei testi dei postmodernisti. Per armarsi di una teoria realmente rivoluzionaria c'è bisogno di tornare a leggere Marx ed Engels, Lenin e Trotsky: non Lyotard, Laclau o Judith Butler.
*Articolo già pubblicato sulla rivista teorica Trotskismo oggi
Note
(1) A proposito dell'incomprensibilità del linguaggio dei teorici postmodernisti, un fumo che spesso non nasconde arrosto, è diventato famoso un esperimento che fece nel 1996 il fisico Alan Sokal, noto come «beffa di Sokal». Lo scienziato scrisse un articolo totalmente privo di senso logico basato sulla composizione di un insieme di concetti e frasi riprese da testi postmodernisti. Lo intitolò "Violare le frontiere: verso un'ermeneutica trasformativa della gravità quantistica" e lo inviò a una prestigiosa rivista femminista postmodernista, che lo pubblicò senza accorgersi che l'articolo non diceva nulla di sensato. Solo in seguito Sokal rivelò che si trattava di una parodia dei testi postmodernisti. Il gustoso aneddoto è in A. Sokal, J. Bricmont, Intellectual impostures, edito in traduzione italiana nel 1999 per i tipi di Garzanti, col titolo Imposture intellettuali. Nel libro gli autori analizzano i testi di Lacan, Baudrillard, Deleuze e altri autori di riferimento del pensiero postmodernista, svelando l'assurdità quanto meno dei riferimenti presuntamente scientifici che spesso accampano nelle loro opere.
(2) Ci riferiamo qui solo al postmodernismo filosofico e politico, per quanto il concetto sia nato in altri ambiti (essenzialmente artistici), in altre epoche e con altre caratteristiche.
(3) Per chi volesse approfondire, suggeriamo alcuni testi che contengono una buona descrizione e critica delle teorie postmoderniste. Precisando che non necessariamente sempre condividiamo le conclusioni degli autori né, tantomeno, la loro collocazione politica. Fatta questa precisazione suggeriamo la lettura di: E.M. Wood, The Retreat from Class: A New 'True' Socialism (1986); S. Wolf, Sexuality and Socialism. History, Politics and Theory of Gay Liberation (2009), la migliore critica che abbiamo letto alle teorie queer e in particolare a Judith Butler; e A. Callinicos, Against Postmodernism: a Marxist critique (1991). Nessuno di questi testi, a nostra conoscenza, è stato finora tradotto in italiano. Di recente è stata pubblicata anche una critica approfondita e puntuale del postmodernismo che offre anche un panorama dei dibattiti sui vari temi: si tratta del gigantesco lavoro di Francisco Erice, En defensa de la razon. Contribución a la crítica del posmodernismo (Siglo XXI, 2020), molto utile anche per orientarsi nella vasta bibliografia sul tema.
(4) Un buon esempio di una concezione determinista volgare, molto simile al dia-mat stalinista ma con la pretesa di presentarsi come «trotskista», si trova nei libri di Alan Woods, principale dirigente della Imt. Si veda ad esempio il monumentale Reason in revolt: dialectical philosophy and modern science, scritto con Ted Grant, una specie di enciclopedia delle scienze e della filosofia (più nelle intenzioni che nei risultati). Ne esiste una traduzione diffusa da Scr, che rappresenta l'Imt in Italia.
(5) K. Marx, Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte (1852), Editori Riuniti, 1997.
(6) F. Nietzsche, Frammenti postumi, 1885-1887, vol. VIII, tomo I delle Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, 1975, pp. 299-300.
(7) Raggruppati sotto il nome di «scuola di Francoforte» (dalla città dove risiedeva l'Università in cui furono attivi inizialmente alcuni di loro) sono filosofi e sociologi che elaborarono a partire dagli anni Venti. Tra i più noti troviamo Theodore Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm.
(8) Con «poststrutturalisti» ci si riferisce in particolare ad alcuni filosofi francesi attivi a partire dagli anni Sessanta. Tra i più noti: Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Luce Irigaray, Roland Barthes.
(9) Che non vi sia nulla «al di là del testo» è la tesi che campeggia in una delle opere centrali di Jacques Derrida, De la grammatologie (1967), edita in italiano da Jaca Book nel 1969 col titolo Della grammatologia (ne esiste una recente riedizione, della stessa casa editrice, del 2020).
(10) J.F. Lyotard, La condition postmoderne (1979), la traduzione italiana è del 1981 col titolo: La condizione postmoderna, Feltrinelli (varie ristampe). Oltre al libro di Lyotard tra gli atti di nascita del postmodernismo va considerato anche il libro di R. Rorty, La filosofia e lo specchio della natura (1979) (Bompiani, 1986), Rorty è in particolare un teorico della cosiddetta «svolta linguistica».
(11) J.F. Lyotard, La condizione postmoderna, Feltrinelli, 2014, p. 45 e sgg.
(12) Il cosiddetto «pensiero debole» si è sviluppato a partire dal libro collettivo del 1983 che reca questo titolo curato da Pier Aldo Rovatti e Gianni Vattimo.
Al libro collaborarono anche Maurizio Ferraris e Umberto Eco, che negli anni seguenti si allontanarono dagli esiti della teoria. Eco polemizza, ad esempio, con le assurdità ermeneutiche cui porta il postmodernismo, nella raccolta di testi I limiti dell'interpretazione (Bompiani, 1990).
(13) E. Laclau, C. Mouffe, Hegemony and Socialist Strategy (1985), edito in italiano da il Nuovo melangolo col titolo: Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica.
(14) Per una ricostruzione dell'autentica concezione materialistica della storia di Marx ed Engels rimandiamo al saggio di Fabiana Stefanoni, "Che cosa non è la concezione materialistica della storia. Il ruolo dimenticato della «prassi rivoluzionaria», in questo stesso numero della rivista.
(15) In particolare, secondo una metodologia già abusata da decine di altri presunti critici del marxismo, Laclau e Mouffe (v. nota 13) estraggono dal contesto alcune frasi di Marx per attribuirgli la paternità del determinismo meccanicista che imperò nella fase degenerata della Seconda e poi della Terza Internazionale e poter così polemizzare con questa arbitraria attribuzione.
(16) E. Laclau, On populist reason (2005), La ragione populista (Laterza, 2008).
(17) Lo scetticismo nei confronti della scienza si traduce in alcuni teorici postmodernisti anche nel rifiuto dei medicinali. In questo senso vanno ad es. le teorie dell'inglese Mark Fisher (Realismo capitalista, 2009, Produzioni nero, 2018) che, pur criticando alcune tesi postmoderniste, ne assume altre. Fisher pone al centro della sua riflessione la questione della malattia mentale e della depressione. Salvo eccezioni, per Fisher le malattie mentali non avrebbero mai una origine neurologica, derivata da squilibri chimici, dunque gli psico-farmaci sarebbero inutili. Assolutizzando due verità - Marx osservava già duecento anni prima di Fisher gli effetti mentali dell'alienazione del lavoro; e grande è il ruolo manipolatore dell'industria farmaceutica - Fisher finisce con l'avallare implicitamente le teorie tanto in voga che vedono dietro ogni farmaco un complotto (v. le posizioni dei no-vax). Si aggiunga poi che la critica di Fisher non va in realtà a colpire il capitalismo ma piuttosto una sua presunta variante cattiva, «neoliberista», e la «meritocrazia». Per questo è stato (si è suicidato nel 2017) un sostenitore di Corbyn. Il suo libro, pieno di affermazioni tanto apodittiche quanto superficiali, è molto diffuso tra i giovani.
(18) A. Gramsci, Quaderni dal carcere, quaderno 11, Einaudi, 1975, p. 1458.
(19) Cfr. K. Marx, F. Engels, La sacra famiglia. Ovvero critica della critica critica. Contro Bruno Bauer e soci (1845), la più recente edizione italiana è in Marx-Engels, Opere, vol. IV, edizioni Lotta Comunista, 2021.
(20) La undicesima delle Tesi su Feuerbach di Marx recita: «I filosofi finora hanno soltanto diversamente interpretato il mondo, si tratta però di trasformarlo.» Su questa e sulle altre tesi, su quale sia la corretta traduzione dall'originale tedesco e sulle lievi modifiche apportate da Engels che le pubblicò dopo la morte di Marx, esiste un'ampia (quanto ingiustificata) polemica esegetica tra gli studiosi. Per uno approfondimento filologico sulle Tesi rinviamo a P. Macherey, Marx 1845. Les theses sur Feuerbach (Editions Amsterdam, 2008).
(21) Non si tratta di una teoria nuova. Già dagli anni Trenta Edward Sapir e il suo allievo Benjamin Lee Whorf elaborarono la teoria (detta «ipotesi di Sapir-Whorf») secondo cui, semplificando, la lingua scopre una verità che resta sconosciuta finché non è nominata. Nella versione di Whorf (che estremizza il relativismo linguistico del suo maestro) il modo di pensare e percepire la realtà sarebbe determinato dalla lingua. Whorf portò a sostegno delle sue tesi, tra l'altro, l'idea secondo cui gli Inuit (una popolazione indigena delle coste artiche dell'America), che usano varie parole per indicare tipi diversi di neve, avrebbero una conoscenza differente del mondo in cui vivono.
Si tratta di teorie, è bene precisarlo, ampiamente smentite dalla scienza: peraltro la stessa esperienza empirica dimostra che è possibile conoscere e pensare un concetto senza essere in grado di esprimerlo con le parole; così come è evidente che chi conosca più lingue non per questo è schizofrenico.
(22) Per Engels il linguaggio ha una natura sociale e così come la coscienza è stato originato dal lavoro nel processo di evoluzione dell'uomo. Scrive Engels: «Insomma: gli uomini in divenire giunsero al punto in cui avevano qualcosa da dirsi. Il bisogno sviluppò l'organo ad esso necessario: le corde vocali, non sviluppate, della scimmia, si andarono affinando, lentamente ma sicuramente, abituandosi a una modulazione sempre più accentuata; la bocca e gli organi vocali impararono a poco a poco a emettere una sillaba articolata dopo l'altra. (...) In primo luogo il lavoro, dopo di esso e con esso il linguaggio: ecco i due stimoli più essenziali sotto la cui influenza il cervello di una scimmia si è trasformato gradualmente in un cervello umano, molto più grande e perfetto secondo ogni verosimile ipotesi».
Si veda il suo: "La parte avuta dal lavoro nel processo di umanizzazione della scimmia" (1876 ma edito per la prima volta nel 1896 sulla rivista teorica della Spd, Die Neue Zeit). Il testo è contenuto in Dialettica della natura, la cui più recente edizione italiana è in Marx-Engels, Opere, vol. 25, edizioni Lotta Comunista, 2022.
Questa teoria di Engels è stata definita scientificamente corretta dal paleontologo Stephen Jay Gould nel suo Ever since Darwin (1977), tradotto in italiano col titolo: Questa idea della vita. La sfida di Charles Darwin, Editori Riuniti, 1990; si vedano in particolare le pp. 209-211.
(23) E. Laclau, C. Mouffe, op. cit. (1985).
(24) L'opera principale di Judith Butler è Gender Trouble (1990), tradotto in italiano come Questione di genere. Il femminismo e la sovversione dell'identità (la ristampa più recente è del 2023 per Laterza). Ma chi, per una qualche forma di masochismo, volesse leggere altri testi dell'autrice, ne troverà in quantità nelle librerie tradotti in italiano e pubblicati da varie case editrici: in particolare Mimesis, ma anche Laterza, Feltrinelli, ecc. Sul linguaggio (che è alla base peraltro di tutte le opere della Butler) si veda ad es. Parole che provocano. Per una politica del performativo (Raffaello Cortina, 2010).
(25) Il termine «woke» significa stare allerta, vigilare, in particolare appunto sull'uso del linguaggio e su alcuni temi che potrebbero risultare offensivi per una identità oppressa.
(26) Lo schwa (che, paradossalmente, è maschile...) è un simbolo grafico ebraico ed è una specie di lettera e rovesciata. Chi voglia approfondire il tema, da un punto di vista scientifico e non meramente legato alla polemica giornalistica, può leggere i testi della linguista Cristiana De Santis, in particolare il suo: "L'emancipazione grammaticale non passa per una e rovesciata" reperibile a questo link https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/scritto_e_parlato/Schwa.html
(27) George Orwell, nel romanzo 1984, scritto nel 1948, immagina una società fortemente repressiva in cui, tra le altre cose, viene imposta una «neolingua» in sostituzione della «archelingua», con lo scopo di cambiare, insieme alle parole, la visione del mondo, eliminando ogni pensiero sovversivo. A vigilare su tutto c'è la «psicopolizia» che ha il compito di reprimere non solo gli atti ma anche ogni idea di disobbedienza al Potere e di sanzionarla prima che possa concretizzarsi (gli «psicoreati»). Il protagonista, Winston Smith, che lavora al Ministero della Verità, ha il compito di censurare articoli e libri e di modificare anche la storiografia conformando il racconto storico alle previsioni del Potere. La «neolingua» non si limita a introdurre neologismi ma modifica la morfologia e la sintassi e, tra le altre cose, la forma dei plurali. Insomma, la somiglianza di certe teorie postmoderniste con la fantasia romanzesca di Orwell è davvero impressionante.