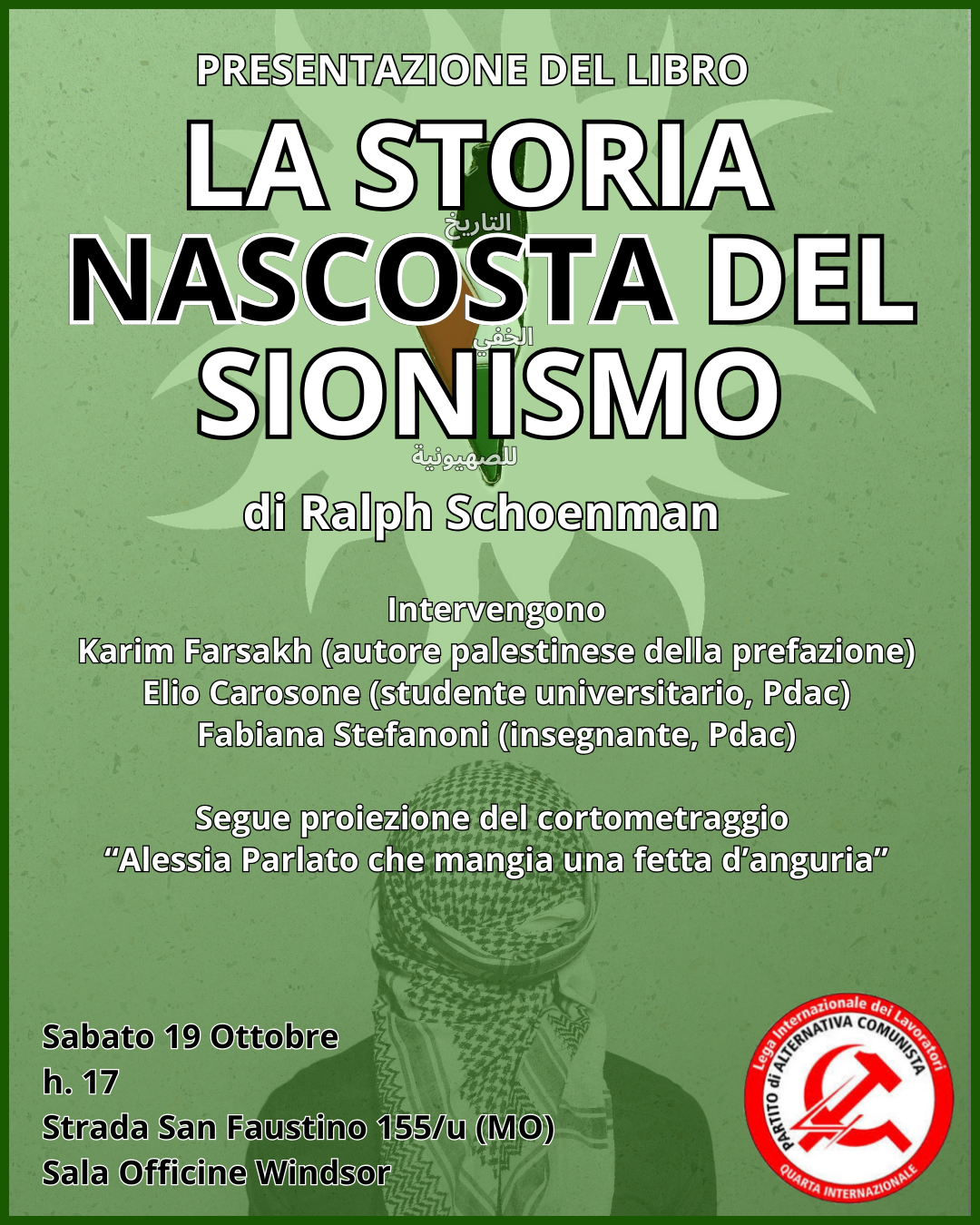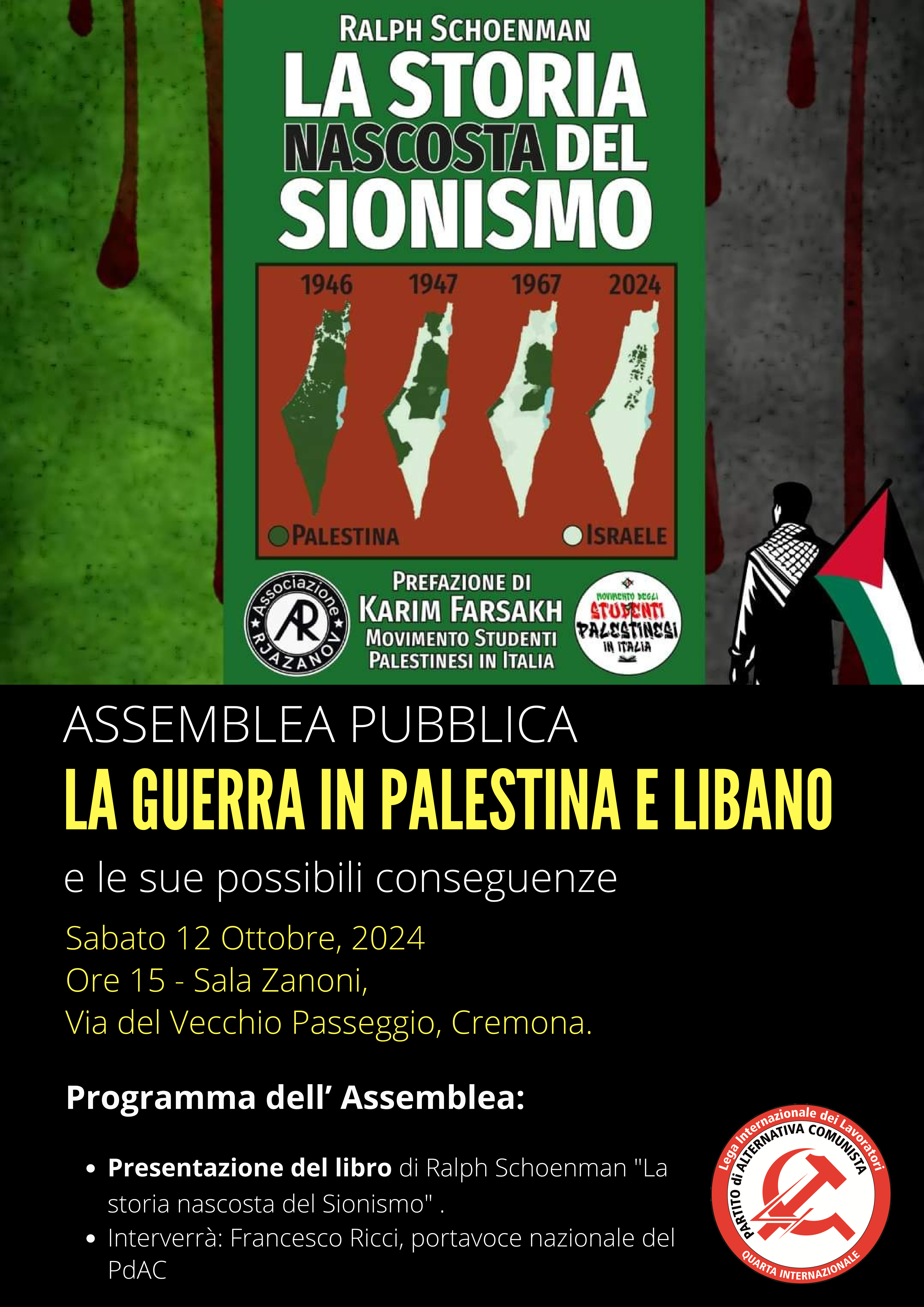Il materialismo dialettico
ed ecologico di Engels
di Jefferson Choma
(Pstu, sezione brasiliana della Lit-Quarta Internazionale)
È innegabile che Marx nutrisse una profonda curiosità per lo sviluppo delle scienze del suo tempo, non solo per le scienze naturali così come per le scienze umane, il che appare evidente dal suo quaderno di studi su Lewis Henry Morgan, che finì per diventare il materiale di base del libro L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, scritto nel 1884 da Friedrich Engels (1820-1895). Tuttavia, fu proprio Engels a dedicare la massima attenzione ai problemi della scienza e al rapporto tra uomini e natura nell’ambito del materialismo dialettico, mentre Marx era assorbito dalle sue ricerche in economia politica, che svelarono gli ingranaggi dello sfruttamento capitalista.
Entrambi lavorarono assieme a un progetto per la costruzione di un'organizzazione indipendente del movimento operaio, basato su un programma rivoluzionario, che si manifestò in iniziative come l'elaborazione del Manifesto del Partito Comunista e, successivamente, nella creazione dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori (AIT).
Fu un Engels maturo che scrisse la Dialettica della natura, un'opera incompiuta contenente solo annotazioni e frammenti per un progetto di libro mai completato. Ciò nonostante, sono molto interessanti i suoi passaggi e le note incomplete su come la logica dialettica possa contribuire sostanzialmente alla comprensione dei processi naturali, a partire da un'approssimazione della scienza con la filosofia, alla luce delle scoperte scientifiche rivoluzionarie di cui fu testimone.
Nel XX secolo, quest’opera fu fortemente criticata da autori come Lukács e altri, influenzati dalla Scuola di Francoforte. Un esempio è il libro La concezione della Natura in Marx, di Alfred Schmidt, un lavoro di dottorato diretto da Max Horkheimer, in cui Engels è accusato di cadere in una metafisica dogmatica e di presentare un'interpretazione della natura slegata da tutta la prassi umana [1]. Engels fu anche accusato di «deviazioni positiviste», poiché egli - così come i positivisti [2] - cercò di applicare un metodo che fosse valido sia nelle scienze sociali che in quelle naturali.
La maggior parte delle critiche a Engels sono prive di qualsiasi riferimento o conoscenza delle scienze naturali, il che ha determinato la totale impossibilità di comprendere in profondità le connessioni ecologiche contenute nel suo pensiero e in quello di Marx. Entrambi non erano alieni alle scienze naturali e alle trasformazioni tecnologiche del loro tempo.
Schmidt, ad esempio, cita il concetto di frattura metabolica di Marx in vari punti. Tuttavia, lo fa in modo astratto, senza mettere in relazione le condizioni materiali naturali e senza spiegare il contesto storico della sua nascita nel pensiero di Marx [3]. In realtà, la sua critica si basa su astrazioni filosofiche che, in molte occasioni, flirtano con l'idealismo.
Nel frattempo, nelle critiche condotte all'opera di Engels, sia da parte degli autori della Scuola di Francoforte che di Lukács, c'era anche, chiaramente, un rifiuto del positivismo e della sua arbitraria trasposizione dai metodi delle scienze naturali alle scienze umane, come fu il darwinismo sociale, un'ideologia reazionaria borghese che serviva a «naturalizzare» il dominio dei capitalisti e lo sfruttamento dei lavoratori. Non fu Engels ad essere un positivista. Il problema è [al contrario ndt] che molti marxisti della II Internazionale furono pesantemente influenzati dall'evoluzionismo.Kautsky, ad esempio, intese il lavoro di Marx come una sintesi tra marxismo e darwinismo e che entrambe [le concezioni, ndt] avessero in comune il fatto di essere teorie dell'evoluzione. Nella sua interpretazione di Marx, «[…] l'evoluzione sociale era quindi situata nel quadro dell'evoluzione naturale; lo spirito umano, anche nelle sue manifestazioni sociali, era spiegato come facente parte della natura […]» [4].
Il principale teorico della socialdemocrazia tedesca intese che le leggi della società potrebbero essere definite come leggi sociali, e il marxismo sarebbe semplicemente un mezzo di ricerca scientifica delle leggi dell'evoluzione e del movimento dell'organismo sociale.Plekhanov, «il padre del marxismo russo», fu un altro autore molto influenzato dall'evoluzionismo. Per lui, né la storia né la natura procedono a salti, il mondo intero cambia solo lentamente e gradualmente. Nel suo modo di intendere, la lotta di classe cessò di essere il motore della storia e cedette il passo all'evoluzione delle forze produttive. «Proprio come Darwin ha arricchito la biologia con la teoria delle specie, tanto ammirevole nella semplicità quanto rigorosamente scientifica, anche i fondatori del socialismo scientifico ci hanno mostrato, nell'evoluzione delle forze produttive e nella lotta di queste forze contro le forme sociali di produzione arretrata, il grande principio della trasformazione delle specie sociali» [5].
Gran parte di questo materialismo dogmatico fu riscattato dallo stalinismo e il «materialismo dialettico» divenne un'ideologia di Stato che servì a corroborare una pseudoscienza materialista al servizio di un'odiosa burocrazia che si era appropriata del potere sovietico. In un certo senso, lo stalinismo ha creato un positivismo invertito: se il positivismo ha cercato di estrarre dalle scienze naturali un'ideologia per naturalizzare le relazioni sociali, lo stalinismo ha ideologizzato le scienze naturali a partire dalla politica.
Il caso Lysenko è uno degli episodi più disgustosi dell'ideologizzazione della scienza nell'Unione Sovietica. Negli anni '30, Lysenko lanciò una goffa campagna diffamatoria contro la genetica mendeliana, sostenendo che non fosse né «dialettica» né «materialista» e che contenesse persino deviazioni borghesi. I genetisti sovietici finirono per essere chiamati «sabotatori trotskisti» sostenitori di una «scienza borghese», il neodarwinismo, cioè la genetica moderna. In contrapposizione, fu promossa un'omonima «genetica sovietica» che negava l'esistenza stessa dei geni e valorizzava «l'ambiente», i «fattori esterni» [6].
Lo stalinismo trasformò il «materialismo dialettico» in un materialismo grezzo travestito di «dialettica» fino a trasformarlo in un documento che tutti gli scienziati dovrebbero venerare citando, talvolta, qualche brano del libro di Engels, alla ricerca di una vera «scienza proletaria». All'interno dell'Unione Sovietica il risultato per le scienze fu catastrofico, specialmente nel campo della biologia, mentre al di fuori di essa molti scienziati si allontanarono dalla dialettica associandola alle atrocità scientifiche commesse dallo stalinismo.
Ma né Engels né il suo libro hanno alcuna responsabilità di questa grottesca deformazione o del fatto che lo stalinismo abbia attribuito precetti ideologici alla ricerca scientifica. Al contrario, le annotazioni di Engels sono una dichiarazione di guerra contro le visioni meccanicistiche e riduzioniste della natura, e non solo contro le forme di pensiero idealistiche contenute nelle scienze naturali. Contro il materialismo grezzo, Engels presenta una visione dialettica delle relazioni uomo-natura e anche del suo modo di vedere i processi naturali. Una visione radicalmente opposta al riduzionismo, che vede fenomeni come frammenti isolati e che, quindi, hanno proprietà che devono essere studiate isolatamente. «L'insieme della natura a noi accessibile - spiega Engels - forma un sistema, una totalità interconnessa di corpi, e per corpi intendiamo qui le esistenze materiali che si estendono dalle stelle agli atomi».
Al materialismo volgare Engels oppone la dialettica come metodo euristico, utile ad una visione più raffinata della complessità della natura e delle scienze che la studiano. Non a caso, il suo lavoro ha influenzato un'intera generazione di biologi anglosassoni molti decenni dopo, come Stephen Jay Gould, Richard Lewotin, Richard Levins, Steven Rose e Leon Kamin, che polemizzarono contro le attuali forme di riduzionismo scientifico, come la sociobiologia che spiega alcuni comportamenti, tra i quali il razzismo e l'aggressività, come geneticamente determinati.
È importante notare che nell'epoca in cui Engels scrisse le sue annotazioni, lo sviluppo delle forze produttive del capitalismo, la filosofia e le scienze naturali progredivano sempre più separatamente l'una dall'altra e si stava sempre più cristallizzando la tendenza alla specializzazione. Le discussioni filosofiche e scientifiche e il suo lavoro hanno cercato di mobilitare le migliori categorie logiche della dialettica hegeliana per sviluppare un approccio filosofico originale dei processi naturali.
Fu in questo lavoro che Engels combatté la nozione di immutabilità della natura e difese la tesi che la materia è in trasformazione permanente, e che ci sono cambiamenti improvvisi, come dei «salti», nel corso dei processi naturali. Ecco da cosa derivava il suo entusiasmo per Darwin, perché vedeva in lui qualcuno che finalmente presentava una concezione della natura che aveva un suo sviluppo storico. Inoltre, la sua conosciuta assertività riguardo alla trasformazione della quantità in qualità ha influenzato la nozione di sviluppo «per salti» presente nella teoria dell'equilibrio punteggiato di Stephen Jay Gould [8].
Un esempio della raffinatezza del suo pensiero è il fatto che Engels fu il primo a vedere nella teoria di Darwin la spiegazione pratica del legame interno tra contingenza e necessità. Ecco come lo spiega:
«Nella sua opera che ha fatto epoca, Darwin parte dalla più ampia base fattuale che poggiava sulla contingenza. Sono esattamente le infinite differenze create dal caso tra gli individui che fanno parte di ciascuna specie, differenze che si accentuano fino a distruggere il carattere della specie e che, incluso le cause più immediate, possono essere dimostrate solo in casi molto rari, che costringono a riconsiderare i fondamenti precedenti di ogni legge biologica: la nozione di specie nella sua precedente rigidità e immutabilità metafisica. Ma senza la nozione di specie, tutta la scienza cadrebbe. Nessuno di questi rami potrebbe ignorare la nozione di specie come base: cosa sarebbero l'anatomia umana e l'anatomia comparata, l'embriologia, la zoologia, la paleontologia, la botanica, ecc. senza di essa?» [9]
Non c'è uno scopo preciso nell'evoluzione della vita. Il processo non avviene con l'obiettivo di formare organismi sempre più complessi o più «evoluti». La selezione naturale non funziona come un ingegnere che lavora su un progetto e cerca la perfezione. Non ha alcun piano definito.
L'emergere di nuove specie è correlato alla variabilità degli organismi. Variazioni che si verificano in modo casuale e vengono ereditate dai loro discendenti. Tali caratteristiche diventano predominanti nelle generazioni successive di una popolazione di organismi che si riproducono, nella stessa misura in cui altre caratteristiche diventano meno comuni e possono scomparire.
Non esiste una forma predefinita verso cui la variazione si inclini mirando a caratteristiche più favorevoli. Al contrario, in generale le variazioni di nuovi organismi non producono vantaggi adattativi all'ambiente, e il loro destino, inesorabilmente, è la loro estinzione. Tuttavia, ci sono variazioni casuali che possono portare a qualche vantaggio adattativo e quell'organismo sopravviverà e trasmetterà le sue caratteristiche ai suoi discendenti. Come afferma Stephen Jay Gould, «l'evoluzione è un misto di caso e necessità, caso nel livello di variazione, necessità nel lavoro di selezione» [10].
Engels, natura e storia
Per quanto riguarda la natura, intesa come processi biogeochimici, Engels condivideva la stessa visione di Marx. Nell’ Ideologia tedesca entrambi criticano i limiti del materialismo statico di Feuerbach, sottolineando la sua incapacità di comprendere il mondo come un processo, come una materia comprensibile nella continua formazione storica, incluso il rapporto della natura con la vita umana pratica.
Marx ed Engels concordano con Feuerbach sul primato dell’ambiente naturale esterno, che si presenta come indipendente dall'esistenza umana, che viene compreso attraverso la nostra capacità sensoriale. Tuttavia, i due pensatori tedeschi vanno molto oltre. Per Feuerbach, la natura è semplicemente contemplativa. Egli ignora che la percezione sensoriale è fatta da uomini storici reali. Su questo punto, Marx ed Engels spiegano:
Egli [Feuerbach] non vede come il mondo sensibile che lo circonda non sia una cosa data immediatamente per tutta l'eternità e sempre uguale a sé stessa, ma il prodotto dell'industria e dello stato di cose della società, e ciò esattamente nel senso che si tratta di un prodotto storico, il risultato dell'attività di tutta una serie di generazioni, ognuna delle quali ha superato la precedente, sviluppando la propria industria e il proprio commercio, modificando il suo ordine in funzione del mutare dei bisogni. (...) Come è noto, il ciliegio, come quasi tutti gli alberi di frutta, è stato trapiantato nella nostra regione attraverso il commercio, solo pochi secoli fa e, quindi, la «certezza sensibile» di Feuerbach è stata resa possibile solo attraverso quell'azione di una determinata società in una determinata epoca [11].
In questo modo, il mondo sensoriale stesso già non esiste più nella sua forma originaria, poiché è diventato il depositario dell'attività prodotta da generazioni successive di uomini, cioè l'ambiente stesso, la natura, è stato continuamente trasformato dall'azione umana. Della natura presentata da Feuerbach, Marx ed Engels ironicamente dicono: «[…] non esiste ai nostri giorni, con l'eccezione, forse, dell'una o dell'altra isola corallina australiana di recente origine […].»
Dalla nascita della specie umana, quindi, è iniziato un processo di trasformazione della natura attraverso la storia e la cultura delle diverse società che si presentarono nel corso della civilizzazione, dal quale non c'è ambiente naturale che non sia stato influenzato, e ogni formazione storica ha sviluppato un suo modo di rapportarsi alla natura. Quindi la famosa frase di Marx, «la natura senza l'uomo è niente», è lontana dalle frequenti interpretazioni idealistiche.
La natura ha il proprio sviluppo determinato da processi biogeochimici, indipendenti dall'azione umana. Ma dall'emergere della specie umana, la nostra storia si intreccia con la storia della natura. Così, sostiene Marx, l'uomo ha sempre avuto davanti a sé «una natura storica e una storia naturale».
Anni dopo, Engels riprende questa discussione in un modo ancora più esplicito:
«Ebbene, non viviamo solo nella Natura ma anche nella società umana, e anche questa ha la sua storia di sviluppo e la sua scienza, non meno della Natura. Si trattava, quindi, di mettere la scienza della società, cioè l'insieme delle cosiddette scienze storiche e filosofiche, in consonanza con la base materialista e di ricostruirla a partire da essa. Questo, tuttavia, non è stato fatto da Feuerbach. Che è rimasto, nonostante la «base», imprigionato nei tradizionali legami idealistici [...] [12]»
Engels ecologista
Ma Engels era anche noto per le sue preoccupazioni ecologiche e per la distruzione dell'ambiente provocata dalla società capitalista. Tali preoccupazioni sono rese esplicite nel suo famoso manoscritto, «Il ruolo svolto dal lavoro nella transizione dalla scimmia all'uomo», in cui Engels presenta una stimolante visione del ruolo del lavoro nello sviluppo degli esseri umani. Confuta la visione unilaterale che la nostra evoluzione sia stata guidata da un cervello in crescita. Il bipedismo ha permesso lo sviluppo del cervello e delle mani; le mani umane sono state liberate in modo che gli esseri umani potessero trasformare la natura e se stessi. Lo sviluppo delle mani è visto da Engels come parte «di un intero organismo estremamente complesso». «Ciò che ritornava a beneficio della mano, ritornava a beneficio del corpo intero, corpo al servizio del quale ella lavorava [...]» (p. 174).
È necessario apportare alcune correzioni a Engels, che suggerisce nel suo manoscritto nozioni lamarckiane come trasmissione di caratteri acquisiti. Solo nel XX secolo la genetica mendeliana confuterà completamente queste idee. Ma non è questo il motivo per cui dovremmo prestare meno attenzione al suo approccio dialettico. La natura è vista come una totalità, un complesso di relazioni di interscambi reciproci, anche tra organismi biotici e abiotici e la loro intima connessione, come Darwin aveva mostrato ed è stato successivamente sviluppato proprio nell’ambito della biologia e della geologia.
Come Marx, anche Engels vide che il lavoro mediava la relazione metabolica tra gli esseri umani e la natura. Il processo del lavoro è una condizione universale del rapporto metabolico uomo/natura. Ma, a differenza di altri animali, c'è uno scopo, un'intenzionalità nell'esecuzione del lavoro umano. Se un animale distrugge qualsiasi vegetazione senza rendersi conto di quell'azione, l'essere umano distrugge una vegetazione per seminare e coltivare il suolo; addomestica piante e animali utili sino punto di renderli irriconoscibili, e li sposta da una regione all'altra, modificando un intero sistema ecologico, trasformandone il paesaggio, appropriandosi dei territori. E così, stabilisce una coevoluzione con il suo ambiente e le creature che ha modificato.
In questa relazione gli esseri umani affermano la propria oggettività e soggettività, modificano l'ambiente e, allo stesso tempo, sé stessi. È attraverso il lavoro che gli esseri umani estendono il loro orizzonte, poiché con la loro azione ogni elemento naturale, ogni potenziale in esso contenuto, mostra proprietà fino ad allora sconosciute. Basti ricordare l'antico addomesticamento delle piante o anche la nostra attuale comprensione dell'energia contenuta in un atomo di idrogeno.
Agendo sulla natura e trasformandola, gli esseri umani approfondiscono i legami sociali tra i membri della società, moltiplicano l'assistenza reciproca, promuovono la cooperazione comune e trasmettono questa conoscenza alle generazioni future. Immaginate, ad esempio, cosa rappresentò per gli esseri umani primitivi l'invenzione di una semplice canoa, che ruppe barriere naturali fino ad allora insormontabili e consentì loro di aprire nuovi orizzonti, rompendo anche limiti geografici fino ad allora insormontabili. Questo ha completamente trasformato la loro concezione del mondo e il loro rapporto con la natura. Ma l’invenzione di una semplice canoa, indipendentemente da quanto rustico e primitivo possa essere stato il suo progetto, richiede di mobilitare e coordinare gli sforzi e le esperienze di un intero gruppo sociale per costruirla: scegliere (o riconoscere) un legno adeguato, mobilitare le persone per tagliarlo, stampare su di esso con il lavoro della mano umana ciò che è stato pensato nel cervello, le forme adatte per galleggiare, fare in modo che resista alle intemperie e alle lunghe traversate, ecc.
Realizzare uno strumento del genere ha suscitato delle attitudini fino ad allora sconosciute a quegli uomini e quelle donne, ha trasformato le relazioni tra loro, ha trasformato l'individuo, la società, la sua visione del mondo, il suo rapporto con la natura, il linguaggio e la specie stessa. Allo stesso modo, anche l'attività della caccia o l'invenzione dell'agricoltura hanno reso gli esseri umani più abili, intelligenti e astuti.
Nonostante esibisca talvolta un certo tono «trionfalista» nelle sue argomentazioni sugli eventi compiuti dalla civiltà, qualcosa di caratteristico del suo tempo che ha visto susseguirsi scoperte scientifiche con una velocità travolgente, Engels rivela allo stesso tempo una profonda consapevolezza ecologica, identificando i limiti della natura. Egli era pienamente consapevole di essere testimone di grandi innovazioni tecniche rivoluzionarie che avrebbero trasformato il mondo, ma ha anche messo in guardia sui problemi ecologici causati da molte di quelle innovazioni e scoperte che potrebbero persino portare alla scomparsa di specie ed ecosistemi. Con un tono di avvertimento sul presunto dominio umano della natura, scrisse:
«[…] Non aduliamoci troppo delle nostre vittorie sulla Natura. È vero che le prime conseguenze di queste vittorie sono quelle da noi anticipate, ma al secondo e terzo posto compaiono conseguenze molto diverse, del tutto impreviste e che, spesso, annullano le prime. Gli uomini che in Mesopotamia, in Grecia, in Asia Minore e in altre regioni hanno devastato le foreste per ottenere terre coltivabili, non potevano nemmeno immaginare che, eliminando insieme alle foreste le riserve naturali per l’accumulo e lo stoccaggio dell'umidità, stessero gettando le basi dell'attuale aridità di quelle terre. Gli italiani delle Alpi, che hanno distrutto sulle sponde meridionali le pinete, così amorevolmente conservate sulle sponde settentrionali, non avevano idea che questo stesse […] privando le loro sorgenti di montagna di acqua e che durante la stagione delle piogge ci sarebbero state inondazioni ancora più furiose. […] Ad ogni passo, la natura si vendica. […] I fatti ci ricordano ad ogni passo che noi non regniamo sulla natura come conquistatori su un popolo straniero soggiogato, come qualcuno che sarebbe al di sopra della natura, ma che ne apparteniamo come [le appartiene, ndt] la nostra carne, il nostro cervello, che ci immergiamo in essa e che il controllo che esercitiamo su di essa risiede nel vantaggio che abbiamo sulle altre creature di conoscere le leggi e di poterle usare ragionevolmente [13]».
In tempi in cui l'umanità è tormentata da una pandemia causata dall'appropriazione mercantile della natura e dai cambiamenti climatici che minacciano l'intera civiltà, quelle parole suonano profetiche e cercano, così, di risvegliare il giusto allarmismo all’interno di una società intossicata dall'ideologia del progresso.
Engels sapeva che lo sviluppo delle scienze serviva ai signori del capitale, consentendo loro di aumentare l'appropriazione del relativo plusvalore. Ma non ha mai presentato una visione unilaterale di condanna dei progressi della scienza, dal momento che essa potrebbe fungere come un mezzo per superare l'alienazione dell'essere umano dalla natura: «[...] più cammineremo su questo sentiero, più ci sentiremo meglio e sapremo che noi e la Natura formiamo una totalità, e sarà sempre più impossibile l'idea assurda e innaturale di un'opposizione tra spirito e materia, tra l'essere umano e la Natura, tra l'anima e il corpo […]» [14].
Ma credere che lo sviluppo scientifico da solo ci salverà dalla catastrofe ambientale, consentendo un rapporto più equilibrato con l'ambiente, è tanto ingenuo quanto ritenere lo sviluppo scientifico responsabile degli squilibri ambientali. Su questo Engels aveva già avvertito: «[…] Per ottenere tale regolamentazione, occorre ben più che semplice conoscenza. Abbiamo bisogno di una rivoluzione completa nel nostro modo di produzione dominante fino ad oggi e, con esso, di tutto il nostro ordine sociale esistente» [15].
La profonda concezione dialettica della dinamica dei sistemi naturali è in perfetta armonia con ciò che Ernst Haeckel chiamava ecologia nel 1866. Ma, come abbiamo visto sopra, lo studio degli ecosistemi deve tener conto dello sviluppo storico delle società. Il «fattore antropico» non dovrebbe essere una mera astrazione di calcolo nello squilibrio del flusso energetico di un ecosistema. È necessario spiegare il motivo dello squilibrio del flusso energetico, che sta nella spiegazione di come è strutturata una società, nelle lotte tra classi sociali, negli interessi economici e nei rapporti di potere che regolano l'appropriazione operata dalle classi sociali di una frazione della crosta terrestre. Alla fine, chi è l'uomo responsabile del riscaldamento globale e della distruzione degli ecosistemi su una scala globale che né Engels né Marx hanno potuto immaginare?
Lo sviluppo della nostra comprensione della natura rafforza l'avvertimento di Engels: «Non regniamo sulla natura come conquistatori». Le pandemie e i cambiamenti climatici causati dal capitalismo richiedono la necessità di superare questo sistema basato sullo sfruttamento del lavoro e della natura. Richiedono la creazione di una società socialista, che rivoluzioni le relazioni sociali e le forze produttive, in modo che gli esseri umani superino la loro alienazione in relazione al prodotto del loro lavoro e si riconoscano come parte della natura, quella che pensa a sé stessa.
Note
[1] La più grande dimostrazione di questo argomento si trova nella seconda parte del primo capitolo dell'opera di Alfred Schmidt, Il concetto di natura in Marx. Madrid: Ed. Siglo Veintiuno, 1977.
[2] Il positivismo è una corrente filosofica emersa in Francia nel XIX secolo, con Auguste Comte, e sviluppata da pensatori come Herbert Spencer ed Émile Durkheim. Il positivismo afferma che la società deve essere studiata con un rigoroso «metodo scientifico imparziale». Per questo, applica lo stesso metodo usato nelle scienze naturali per lo studio delle scienze sociali. Durkheim, ad esempio, ha paragonato la società a un organismo biologico, «un sistema di organi in cui ognuno ha il suo ruolo particolare». Alcuni organi hanno una situazione speciale e privilegiata, naturale per il buon funzionamento di qualsiasi organismo. In questo modo, il positivismo giustificava il privilegio di classe e l'ordine sociale stabilito. Il darwinismo servì quell'ideologia quando concetti come «sopravvivenza del più adatto» furono importati nelle scienze sociali per giustificare il dominio di classe.
[3] Per saperne di più, leggi: https://www.pstu.org.br/usar-marx-para-entender-e-enfrentar-a-crise-ecologica/
[4] Kautsky, Karl, Las tres fuentes del marxismo. San Pablo: Centauro, 5° ed., 2002, p. 17.
[5] Plejànov, G. V. Los Principios Fundamentales del Marxismo. Disponibile al link: https://www.marxists.org/portugues/plekhanov/1908/principios/index.htm
[6] Lysenko disprezzava molti aspetti della teoria dell'evoluzione di Darwin e suggeriva un approccio evolutivo che si ispirava all’idea di Jean-Baptiste Lamarck dell'inizio del XIX secolo, secondo cui gli organismi potevano acquisire tracce nelle loro vite e trasmetterle per eredità ai loro figli. Radicato sull'argomento che il cambiamento genotipo è il risultato di influenze esterne, dell'ambiente, Lysenko è entrato in guerra contro la genetica mendeliana e contro il botanico Nikolai Vavílov, il suo difensore più notevole. Quella teoria, nel frattempo, era già completamente obsoleta all'epoca e mancava totalmente di prove empiriche. La maggior parte dei biologi evoluzionisti, come Vavílov, ha difeso la tesi che nei processi evolutivi le caratteristiche di un organismo vivente siano geneticamente ereditate dai suoi antenati.
[7] Utz, Konrad; Soares, Marly Carvalho (Org.). A noiva do espírito: naturaleza en Hegel [La novia del espíritu: naturaleza en Hegel]. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010.
[8] Per saperne di più: Gasper, Phil. E«l biólogo dialéctico, Stephen Jay Gould», in: Marxismo Vivo n.° 6, novembre, 2002. Disponibile al link: http://marxismovivo.org/wp-content/uploads/2019/01/Primera-Epoca/POR/MV6/MV6pt/mv06pt.pdf
[9] Engels, Friedrich. Dialéctica de la Naturaleza, Lisboa: Ed. Presença, 1974, p. 230.
[10] Gould, Stephen Jay. Darwin y los Grandes Enigmas de la Vida, San Pablo: Martins Fontes, s/d, p. 2.
[11] Marx, K; Engels, F. La ideología alemana, San Pablo. Ed. Boitempo, 2005, p. 32.
[12] Engels, Friedrich. Ludwing Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Disponibile al link: https://www.marxists.org/portugues/marx/1886/mes/fim.htm
[13] Engels, Friedrich.Dialéctica de la Naturaleza. Lisboa: Ed. Presença, 1974, pp. 182-183.
[14] ídem, p. 183.
[15] Ídem, p. 184.
[traduzione dallo spagnolo a cura di Salvatore de Lorenzo]